Stefano Liberti appartiene a una specie oramai in estinzione: il giornalista d’inchiesta. Quello vero, che inizia informandosi sul Web o sui media ma poi compie ricerche sul campo, intervistando e dando il giusto spazio a punti di vista differenti su di un medesimo fenomeno; che parte con delle proprie opinioni ma senza atteggiamenti dogmatici, pronto a modificarle di fronte a una realtà diversa da quella immaginata, mettendo da parte amicizie e antipatie; che vince premi giornalistici a ripetizione e che, per tale ragione, ti aspetteresti corteggiato da tutte le principali testate (una sorta di Cristiano Ronaldo della categoria), che però sembrano accorgersi di lui solo sporadicamente (in questo mi ricorda un collega altrettanto valido, Pietro Dommarco)…
Personalmente avevo già letto e apprezzato i precedenti Land Grabbing e A sud di Lampedusa, ma I signori del cibo l’ho letteralmente divorato viaggiando da Ravenna a Novara in treno regionale (sarebbe stato impossibile con l’alta velocità! Slow train for high culture!). Anche se sono un lettore abbastanza rapido, farsi fuori tutto d’un fiato 327 pagine in quattro ore, senza soste che non fossero quelle relative alle fermate per prendere le coincidenze, è impresa disperata se il libro non risulta interessante e coinvolgente.
Liberti non lo dice esplicitamente, ma quest’opera rappresenta in un certo senso il logico completamento di un percorso intellettuale iniziato con i primi due libri: un filo rosso lega indissolubilmente l’accaparramento di terre nel sud del mondo, l’emigrazione e l’industria alimentare. Invece di discorsi sui massimi sistemi, l’analisi è costruita analizzando sul campo, dall’origine fino alla destinazione finale, la filiera di quattro prodotti: carne di maiale, soia, tonno, pomodoro. Per quanto le persone un po’ informate sappiano già che l’agrobusiness, nonostante i suoi record produttivi, è sostanzialmente un gigante dai piedi di argilla, è incredibile come la realtà possa superare le peggiori fantasie.
Il maggior merito di Liberti è di unire alle doti di cronaca del giornalista la capacità tipica dell’intellettuale di collegare i fatti e tracciare un quadro di insieme coerente, superando superficialità e sensazionalismo. Vi propongo alcuni estratti del capitolo finale, dove inquadra il fenomeno del caporalato legato alla raccolta dei pomodori nell’Italia meridionale all’interno di una riflessione più ampia che sintetizza quanto ha osservato per il mondo e descritto nel libro:
… questi ultimi [gli immigrati sfruttati dai caporali, n.d.r.] non sono schiavi. Sono impiegati a giornata, certamente ricattabili e quasi del tutto privi di potere negoziale, ma che nessuno costringe a lavorare in catene. La distinzione non è un mero esercizio semantico: definendo questi braccianti schiavi e dando al fenomeno una coloratura arcaica, quasi marginale, lo si relativizza, riducendolo al rango di anomalia locale. Invece, il sistema non riguarda solo il Sud Italia con le sue sacche di illegalità e d’intermediazione illecita… Il bracciantato regolato dai caporali in Puglia è l’espressione di un movimento che si dispiega a livello planetario.
Questo movimento è la diretta conseguenza dell’offensiva delle aziende-locusta che lavorano sui grandi numeri, trasportano i prodotti alimentari da un capo all’altro del pianeta e si assicurano margini di guadagno grazie alle loro economie di scala, ai loro network commerciali e politici, alla loro potenza di fuoco. Sono i gruppi che muovono le navi-container piene di soia dal Brasile ai porti cinesi e i carichi di pomodoro concentrato dagli stessi porti verso altre direzioni. Sono quelli che riunchiudono in capannoni centinaia di migliaia di maiali nutrendoli con la soia brasiliana. Sono quelli che inscatolano ed esportano il tonno che sta scomparendo dai nostri mari. Sono quelli che comprano il pomodoro raccolto dai bambini nello Xinjang pagati un tot al metro o dagli africani senza documenti nel Sud Italia pagati un tot a cassone.
Riassumendo schematicamente: i brasiliani usano le loro terre per produrre soia che viene ingurgitata dai maiali industrializzati che la Cina ha importato dagli Stati Uniti; i cinesi usano le loro campagne per produrre il concentrato di pomodoro che verrà esportato in Africa o servirà da base al ketchup negli hamburger che i fast food come McDonald’s vendono in tutto l’Occidente – e che stanno cominciando a spopolare in Cina. (pag. 314-315)
Questa descrizione trasuda non solo di ingiustizia, ma di spreco, insostenibilità e spregio dei principi elementari della termodinamica, fattori che forse Liberti non sottolinea a sufficienza. A fronte di dibattiti sentiti ma piuttosto sterili del tipo ‘beni relazionali-ripresa del contatto con la terra-genuinità vs efficienza e potenza dell’agro-industria’, dove a farla da padrone sono le opinioni personali, i reportage de l signori del cibo urlano a squarciagola “il re è nudo”, denunciando un paradigma alimentare industriale che – malgrado gli strabilianti exploit che hanno convinto molte persone a tollerarne le storture a livello sociale e ambientale – è condannato a morte certa a causa della sua intrinseca illogicità. Nel libro, Liberti narra l’incontro con gli allevatori aderenti al movimento del CSA (Community Supported Agricolture), con gli agricoltori biologici, con i pescatori fautori di pratiche a basso impatto ambientale: per quanto solidarizzi con loro e comprenda la validità delle loro ragioni, inevitabilmente si chiede quanto tali proposte di nicchia, spesso più costose delle controparti industriali, possano realmente fare la differenza in un mondo in costante crescita demografica e dove nei paesi emergenti si stanno diffondendo e consolidando stili di vita occidentali. Si tratta di un interrogativo scomodo e che nessuno può eludere, anche perché implicitamente ci fa capire che l’ostinazione nelll’ignorare i problemi perpetuando imperterriti il business as usual potrebbe averci condotto a un punto morto in cui una ‘soluzione’ vera e propria (intesa come rimedio sostanzialmente indolore) non esiste più. Eppure quelle proposte alternative, con tutti i loro limiti, rappresentano l’unica risorsa su cui costruire un mondo che sappia rigenerarsi dall’avidità e dalla distruzione causate dalla logica perversa delle aziende-locusta, e solo il loro sviluppo e la loro valorizzazione può essere fonte di speranza.
Immagine in evidenza: copertina de I signori del cibo, dal sito Web di Minimun Fax.

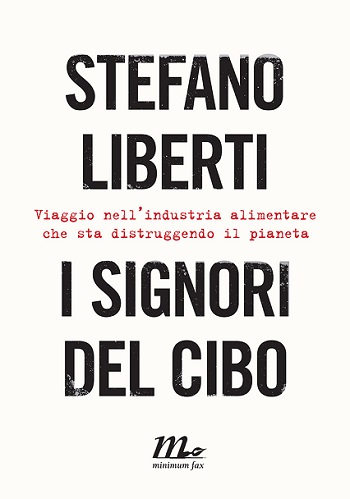









https://www.youtube.com/watch?v=phCu3sHZOj0
Una proposta alternativa molto promettente. Si definisce “promotore in prima persona della decrescita felice”
Nel suo libro “La civiltà dell’orto” si parla di autosufficienza in 210 metri quadrati, con un solo giorno di lavoro alla settimana per una sola persona, con mansioni talvolta impegnative e mai faticose.
Inoltre non viene praticata nessuna lavorazione del terreno (solo pacciamatura), nessun uso di fertilizzanti, antiparassitari, ammendanti, e diserbanti nè chimici nè organici.
Porta la propria pratica di coltivazione orticola naturale presso realtà sociali rivolte all’autosufficienza alimentare: eco-villaggi, comunità, orti urbani condivisi, orti didattici, etc.
Ciao Angelo, se ti va puoi fare un articolo/recensione sul sito.
Grazie, ma in genere mi limito a far girare gli articoli e le letture che trovo più interessanti. Una specie di passa-parola approfittando degli spazi messi a disposizione da certi siti per i commenti.
Per quello che ho potuto sapere, questo Gian Carlo Cappello è già conosciuto e stimato in certi ambiti ma il suo metodo di coltivazione meriterebbe di essere considerato più approfonditamente. Nella semplice messa in pratica dei suoi precetti si cela forse la soluzione ai tanti dilemmi che attanagliano l’agricoltura contemporanea.
[…] chiedono un libro di facile lettura per comprendere la globalizzazione, immancabilmente consiglio I signori del cibo di Stefano Liberti. Dei quattro capitoli che lo compongono – uno per ogni alimento indagato – […]